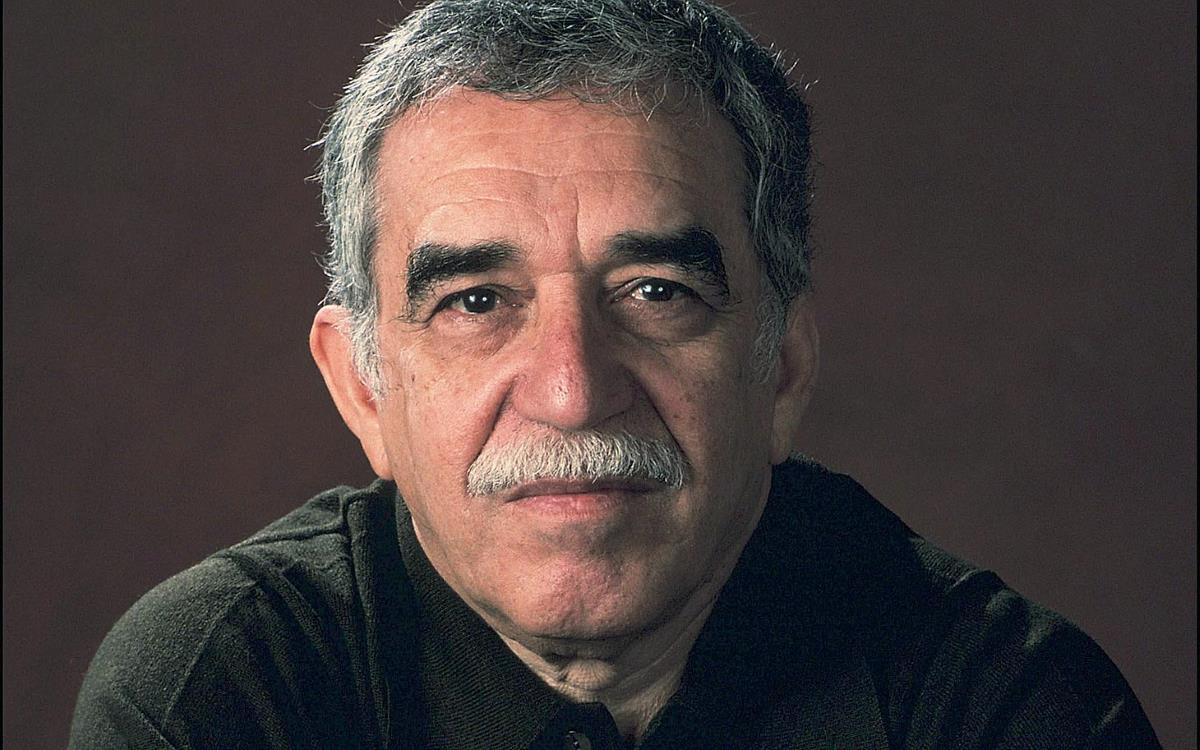di Antonio Salvati
Davanti a un mondo molto frammentato, come quello odierno, dilaga lo spaesamento con conseguenti difficoltà a confrontarci con la realtà, sia in termini culturali che politici. Questa situazione è caratterizzata dal divorzio tra cultura e politica: si può fare politica senza sapere ma “intuendo”, percependo, reagendo di pancia. Si tratta di un’illusione che lascia aperta una sola porta: affidarsi totalmente all’approccio emergenziale, che offre il vantaggio di “produrre notizie” ogni momento, di arrivare prima e di dire le cose giuste. Stando sempre sulla scena mediatica, la politica stessa s’indebolisce, si svaluta e si banalizza, sottoponendosi continuamente al superficiale scrutinio della contrapposizione che provoca infinite repliche di esasperazione, avversione o di sostegno.
Sulla frattura registratasi nell’ultimo trentennio tra politica e cultura e sulle ragioni che negli ultimi decenni hanno indotto politici e intellettuali a ritenere di poter fare a meno gli uni degli altri, ha indagato Giorgio Caravale con il volume, Senza intellettuali. Politica e cultura in Italia negli ultimi trent’anni, (Laterza 2023, pagine 168, euro 18,00). L’autore si sofferma su una stagione storica in cui l’«età dell’incompetenza» ha fatto «da sfondo a una politica sempre più aliena da un’approfondita elaborazione culturale e a un ceto intellettuale sempre più chiuso in sé stesso, disinteressato alla politica quando non esplicitamente infastidito dalle sue dinamiche», ricostruendo gli snodi fondamentali che hanno segnato l’evoluzione del rapporto, o del non-rapporto, tra politica e intellettuali e la profonda trasformazione del contesto culturale nel quale tale dinamica si è sviluppata.
Caravale auspica che politica e cultura, «imparando a rispettare maggiormente l’autonomia l’una dell’altra, riusciranno a ricostruire un rapporto oggi inesistente». Non solo. Rimane convinto che la definitiva archiviazione della stagione ricostruita nelle pagine del suo libro «non passi per il lamento sul presente né tantomeno per il rimpianto dei tempi andati. Solo prendendo sul serio il trentennio appena conclusosi, solo comprendendo appieno la svolta maturata in questo tornante di inizio millennio, potremo autorizzarci a pensare modalità nuove di dialogo e collaborazione tra politica e società civile e, dunque, tra politica e intellettuali».
Molti ricorderanno le considerazioni di Berlusconi sugli intellettuali bollati come portatori di «una cultura dannosa e perdente», assecondando e sostenendo un trend già fortemente affermatosi nel decennio precedente, quando la crisi delle ideologie e del pensiero critico, le nuove logiche dell’industria culturale, la dittatura dei grandi numeri e del marketing, la disintegrazione della «società intellettuale» ancor prima di quella letteraria, avevano contribuito a dissolvere lo strettissimo nesso tra politica e cultura del quale si era alimentato l’«impegno» di molti di loro. In altri termini, Berlusconi con la sua discesa in campo e la sua repentina vittoria elettorale avevano messo sottovuoto la sinistra intellettuale, relegandola in un atteggiamento pretenziosamente aristocratico le cui radici «affondavano nel disdegno per lo spirito “vacuo ed effimero” della cultura televisiva e nell’incapacità di abbandonare un modello culturale limitato alla critica dell’esistente».
Una miscela di autoreferenzialità e massimalismo aveva così rafforzato nell’opinione pubblica l’immagine dell’intellettuale settario e intollerante intorno alla quale il leader di Forza Italia consolidò la sua vincente propaganda elettorale. Nel rinunciare a qualsiasi forma di impegno politico, gli intellettuali di sinistra non solo espressero fortemente i timori di una minacciosa avanzata della destra con una pungente polemica rivolta contro una sinistra politica accusata di averne favorito l’ascesa. Nel 1994 molti di loro avevano rifiutato anche solo l’ipotesi di una candidatura e due anni dopo, alle soglie della pur momentanea rivincita di Romano Prodi contro Berlusconi, si erano ben guardati dal partecipare attivamente alla contesa elettorale. Presentatisi come detentori di un progetto pedagogico destinato a educare e raddrizzare l’Italia e gli italiani, gli intellettuali di sinistra – spesso dipinti dalla retorica berlusconiana come membri di un ceto autoreferenziale e arrogante – suscitavano il forte fastidio di una parte non minoritaria degli elettori italiani. Il Cavaliere cavalcò abilmente questo sentimento, proponendo una narrazione alternativa centrata sulle virtù degli italiani e sull’elogio della morale dell’«arrangiarsi».
Anticomunismo e antintellettualismo si saldarono dunque nella retorica berlusconiana intorno al mito antipolitico di una società del fare contrapposta alla società del dire. Il secondo decennio del XXI secolo è stato l’apogeo dell’antintellettualismo populista. Il M5s di Beppe Grillo e la Lega di Matteo Salvini in particolare, espressero una retorica che unì l’ormai radicato sentimento antipolitico con la crescente avversione contro gli esperti di ogni campo del sapere, gli intellettuali in particolare. La figura dell’intellettuale fu sin dagli esordi uno dei bersagli prediletti del sarcasmo a 5 Stelle. Grillo – ricorda Caravale – comunicava ai suoi lettori (ed elettori) che scienziati, giornalisti (e i giornaloni), letterati, giuristi, economisti erano impostori che abusavano della loro credulità. L’unica forma possibile di sapere era quella che discendeva dal vertice alla base, dal capo al popolo, senza filtri e mediazioni: via web. Come è stato scritto, una sorta di egualitarismo narcisistico e disinformato sembrò avere la meglio sul tradizionale sapere consolidato. Il fondatore del M5s – in maniera impressionante ed inquietante – e i suoi seguaci celebravano l’incompetenza e l’inesperienza come prova regina di integrità morale. Mentre gli intellettuali, «in prevalenza di sinistra», erano quelli mai «sfiorati dal dubbio», sempre «sorretti […] da un intelletto fuori misura per i comuni mortali», «fantasmi che non riescono a toccare palla nel mondo reale», «autistici psicopatici con la sindrome di Asperger che vanno avanti per ore a parlare senza capire che chi gli sta davanti non sta capendo quello che lui dice». Tra il primo e il secondo decennio del XXI secolo, quindi, i partiti italiani non concepirono più la storia come un contenitore dal quale estrarre i contenuti finalizzati a legittimare e valorizzare la propria identità politica presente e futura, bensì – ahinoi! – come un qualcosa di assai fastidioso della quale fare volentieri a meno. E pensare che durante la cosiddetta Prima Repubblica abbiamo avuto segretari di partito che erano storici, come nel caso di Giovanni Spadolini. Anche in politica arrivò la stagione del cosiddetto presentismo: il «regime di storicità», ossia il modo come una società tratta il proprio passato e ne parla, individuato dal filosofo francese François Hartog come il più caratteristico dei nostri tempi.
Eppure, nell’Italia del secondo dopoguerra, molti rappresentanti del mondo politico (soprattutto del Pci di Palmiro Togliatti) fecero della storia il terreno naturale e prediletto della propria politica culturale. Per il PCI lo studio della storia, nella visione togliattiana, aveva l’obiettivo di restituire a cittadini ed elettori il senso dell’indispensabile ruolo svolto dal comunismo e dalla lotta di classe nel panorama politico italiano e mondiale. I comunisti italiani presero molto sul serio il proprio ruolo di storico-intellettuale di partito. Il partito, nella visione gramsciana del Pci, era inteso come un intellettuale collettivo che elaborava collettivamente la concreta esperienza storico-politica del momento. Come ha ricordato lo storico francese François Furet, «l’illusione comunista» fece della storia «il suo pane quotidiano»: il comunismo divenne presto «un credo nella salvezza attraverso la storia» e «tutto quello che accade[va]» veniva «integrato di continuo nel suo credo». Anche la DC condivise – ha scritto Pietro Scoppola – la stessa visione teleologica della storia avallata dalle grandi ideologie di matrice marxista. Il noto progetto di una “nuova cristianità” (di ispirazione montiniana) che caratterizzò la classe dirigente democristiana, scaturiva da una concezione deterministica della storia secondo la quale gli uomini possono prevedere e dominare gli eventi nel loro sviluppo di lungo periodo.
Sul divorzio tra politica e cultura – ritengo – ne soffre la politica che si fa sempre più “corta”, sottomessa al presentismo degli annunci e dei fuochi d’artificio degli scontri, una politica senza tempo, molto personale, senza respiro. Ne soffre anche la cultura che inizia a confondersi con l’informazione, con tutti i difetti che sappiamo: le fake news, ecc. Nel mondo globale di oggi, si ha la sensazione di vedere tutto quello che si vuole e di poter raggiungere tutto. Ma avere tante notizie non vuol dire elaborare un pensiero o una visione. Vediamo tanto, ma senza una prospettiva, una visione come accadeva nel Novecento. Abbiamo – ha osservato Andrea Riccardi – tante informazioni ma senza una cultura che le ordini e le filtri, che dia le priorità, che tracci una prospettiva. Ciò aumenta lo spaesamento e provoca false impressioni. Bisogna anche riprendere a vivere la storia, che non è solo un cumulo di macerie e di errori, su cui l’unica cosa che si può fare è realizzare messianicamente qualcosa di nuovo. Non tutto è sbagliato nell’Italia della Prima Repubblica, in quella di Berlusconi e di Prodi, in quella di ieri.
E’ la nostra storia. Umberto Eco, nel 2013 diceva saggiamente all’ONU: «in un mondo in cui si è tentati di dimenticare o di ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere tra i primi progetti del nostro futuro». La riconquista del passato, come storia comune, e l’affermazione di una dimensione dialogica della vita sono il terreno in cui maturano le visioni del futuro. La visione è anche una spinta alla libertà, nel superamento, al sogno, alla crescita: non è solo fuggire da un passato di rovine credendo miticamente di trovare un futuro migliore. Da dove ripartire dunque? Credo che ci sia bisogno di cultura e d’incontro per innervare la politica. Non è possibile vivere un tempo complesso come il nostro senza interrogarsi, discutere, leggere, altrimenti si è trascinati dai vanti e dalle correnti. Le semplificazioni e le paure si annidano nell’ignoranza. Per prepararsi all’impatto con il mondo globale, la nostra società avrebbe bisogno di un investimento sulla cultura, che non c’è stato. Coltivare visioni è cultura, memoria storica, incontri, amicizia, dialogo: un orizzonte in cui inquadrare notizie, gestire messaggi dei media e dei social.