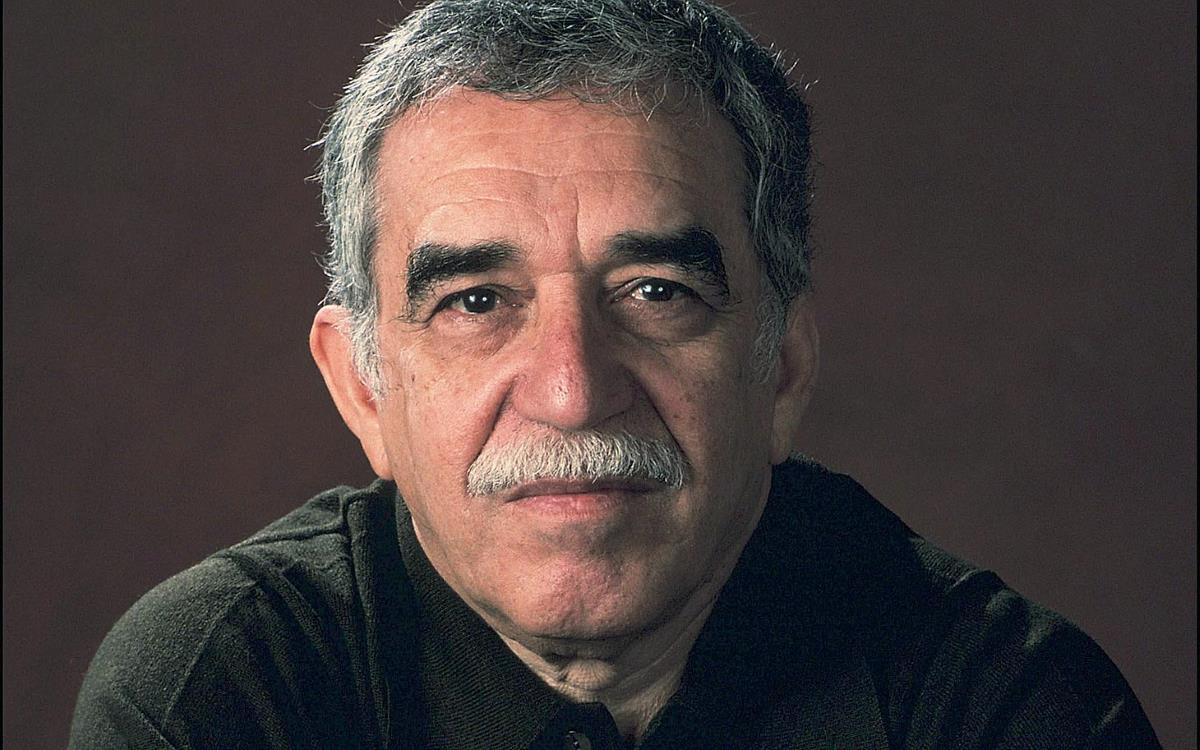di Rock Reynolds
Un’altra concione melensa di stampo “peace and love”?
Ci si stanca facilmente di tutto ciò che puzza di stantio. Entusiasmo e passione si spengono di fronte a banali ostentazioni di sofferenza e a pomposi proclami di adesione a movimenti pacifisti che suonano privi di autenticità.
Ma Una volta ero un soldato (Il Saggiatore, traduzione di Diana Petech, pagg 184, euro 17) di Claude AnShin Thomas non c’entra nulla con quel mondo. Una volta ero un soldato è un grido di dolore e al tempo stesso una dichiarazione di serenità conquistata con il coltello tra i denti, verrebbe da dire, se l’immagine non stridesse con l’anelito di pace che lo percorre, è un salutare pugno nello stomaco del lettore e una coraggiosa denuncia dell’immobilismo culturale che il pensiero occidentale mostra da troppo tempo. È pure una critica impietosa del qualunquismo di un certo movimento pacifista.
Ma andiamo per gradi. Claude Thomas era un giovane pieno di buoni propositi patriottici come ce n’erano tanti negli Stati Uniti allo scoccare della grande stagione dei cambiamenti di fine anni Sessanta. Figlio di un reduce della Seconda guerra, non ha atteso la coscrizione e si è invece offerto volontario per andare in Vietnam a combattere lo spettro del comunismo, in nome di una democrazia immacolata le cui imperfezioni hanno impiegato poco a manifestarsi e il cui architrave valoriale ha presto mostrato forti scricchiolii. Il sistema militare, varrebbe la pena di ricordarlo, non è un surrogato della famiglia e della scuola da nessuna parte. Non lo era e non lo è negli USA e non lo è stato e non lo è nemmeno ora anche in Italia. La storiella secondo cui i valori dei militari – patria, coraggio, lealtà, cameratismo – sarebbero universali è una plateale mistificazione di una realtà ben meno nobile. Il sistema militare addestra a uccidere e, per giunta, a farlo nel modo più efficiente e scientifico possibile.
AnShin queste riflessioni non era in grado di farle prima di arruolarsi – schiacciato dal peso della sofferenza di un genitore che non era mai riuscito a parlare degli orrori della guerra e accecato dalla propaganda – e non è stato certamente in grado di farle mentre era impegnato a restare vivo in Vietnam.
Come molti reduci, i guai e i ripensamenti sono iniziati quando, una volta riportata la pelle a casa, la fosca quotidianità e la realizzazione di non essere poi così importante come lo Zio Sam gli aveva fatto credere gli hanno aperto gli occhi. Il dramma vero si è manifestato in quel momento. «Volevo solo morire – ma allo stesso tempo non volevo davvero morire: semplicemente non sapevo come vivere, con dentro tutto quel dolore.» Perché il sistema militare insegna a dire di sì e a combattere e uccidere, ma non si preoccupa particolarmente di predisporre un soldato a ciò che potrebbe succedergli se dovesse restare offeso per sempre nel cuore e nel fisico. E il sistema militare americano, da quel punto di vista, è probabilmente peggiore di altri, proprio perché rappresenta un punto fermo della società a stelle e strisce. «Che dire della nostra cultura, noi americani, se non che sembriamo prosperare sulla violenza, sia reale che rappresentata, al punto da farla diventare il piatto forte della programmazione dei media? Quando poi la violenza ci colpisce vicino a casa, come nella sparatoria al liceo di Columbine, cerchiamo una scusante – la psicopatologia degli adolescenti, le loro famiglie disfunzionali – invece di riconoscere che le azioni di quei ragazzi sono il riflesso dell’etica della società più vasta.»
Le parole di AnShin manifestano una serenità interiore che non sempre ha avuto. L’incontro con il buddismo e, in particolare, con lo Zen Soto e la pratica meditativa di ZaZen è stato la scintilla che gli ha consentito di ritrovare se stesso e di scendere a patti con la sua coscienza tribolata. Attraverso la meditazione, incentrata sul controllo del respiro e del corpo fino a entrare in simbiosi con l’universo, gli ha reso la vita «più chiara, più fluida, più semplice, anche se non necessariamente più facile. Come ha insegnato il Buddha, la vita è sofferenza: non è che questa verità scompaia, quando pratichiamo la presenza mentale, a cambiare è ciò che pensiamo, proviamo e facciamo di fronte a quella sofferenza».
Come detto, il momento in cui la verità si è palesata quasi con violenza di fronte agli occhi di AnShin è stato quando, dopo aver ammazzato decine di persone in Vietnam, è rientrato in patria ed è uscito dall’esercito. È stato allora che si è reso conto che, malgrado un profluvio costante di belle parole, il reduce di guerra non era un eroe bensì uno scomodo peso per la società, un peso da nascondere. Abusi di ogni sorta hanno trasmesso un senso malato di cameratismo ad AnShin, accomunandolo a migliaia di ex-commilitoni affetti da fortissimi sintomi della sindrome da stress postraumatico. Una triste constatazione che per AnShin, persino in anni recenti, durante pellegrinaggi rituali in tutti gli Stati Uniti, si è fatta ancor più intensa. «Ho osservato un senso di isolamento più forte – tra le comunità, le famiglie e gli individui – rispetto a quello che avevo osservato durante il mio precedente pellegrinaggio attraverso il paese… Mi sono anche reso conto di un acuto incremento del livello di paura.»
La sofferenza repressa e la negazione sono due bruttissime gatte da pelare. Oggi AnShin lo sa benissimo e della condivisione di tale consapevolezza ha fatto una sorta di missione. Come ci ha lasciato intendere.
Ci dica com’è che ha imboccato questo suo nuovo corso, scoprendo lo Zen Soto. Com’è avvenuto.
Sostanzialmente per caso.
Perché dice che la generazione di suo padre e dei reduci della Seconda guerra non ha saputo raccontare le proprie esperienze?
Semplicemente, era in quel modo che gli era stato insegnato ad affrontare le avversità, le difficoltà: non parlatene e non ce ne saranno.
Crede ancora che, per raggiungere la serenità, dobbiamo prima attraversare la sofferenza e accettarla?
Sì, inoltre dobbiamo rinunciare alle idee preconcette su come possa essere la serenità.
Da soldato, le è mai passato per la testa che gli insegnamenti che le venivano dati potessero essere sbagliati?
No, mai.
Come reagì quando scoprì che la guerra in Vietnam non era per la democrazia? E cosa pensava del pacifismo al tempo?
Ho combattuto per restare vivo e per mantenere vive le persone che avevo intorno. Il movimento pacifista in larga parte non era altro che un diverso movimento militarista, nel senso che vedeva una parte come il proprio nemico. Quel nemico era rappresentato dalla gente e dalle istituzioni che non ne condividevano la visione del mondo.
Secondo lei è davvero impossibile risolvere la questione delle armi da fuoco negli USA?
No. Non si tratta di qualcosa di impossibile da affrontare.
Crede che la guerra sia inevitabile?
No. La conflittualità è inevitabile. Ma, attraverso una pratica spirituale disciplinata e radicata nell’autoriflessione, la si può affrontare, capendo che le radici della guerra esistono dentro ognuno di noi, con l’impegno a guarire le radici della guerra che esistono in noi… È così che la conflittualità non degenera necessariamente in guerra, violenza e aggressività.
Come mai scrive che l’Italia, che ha visitato, non ha fatto del tutto i conti con il suo passato fascista?
Per via della ritrosia della maggioranza della società e della cultura italiane a parlare apertamente del proprio ruolo nella grande sofferenza che è stata la Seconda guerra e a riconoscerlo. A tutti piace parlare dei partigiani. A pochissimi, forse a nessuno, piace parlare delle leggi razziali.
Sulla base delle sue esperienze, che suggerimenti si sente di dare a un giovane d’oggi?
Dare suggerimenti non è il mio mestiere. Ciò che sottolineo e pratico con forza attraverso la mia vita è che la causa della mia sofferenza non è esterna e che, dunque, nemmeno le soluzioni sono esterne. Se voglio che il mondo sia diverso, io devo essere la differenza che voglio vedere nel mondo.