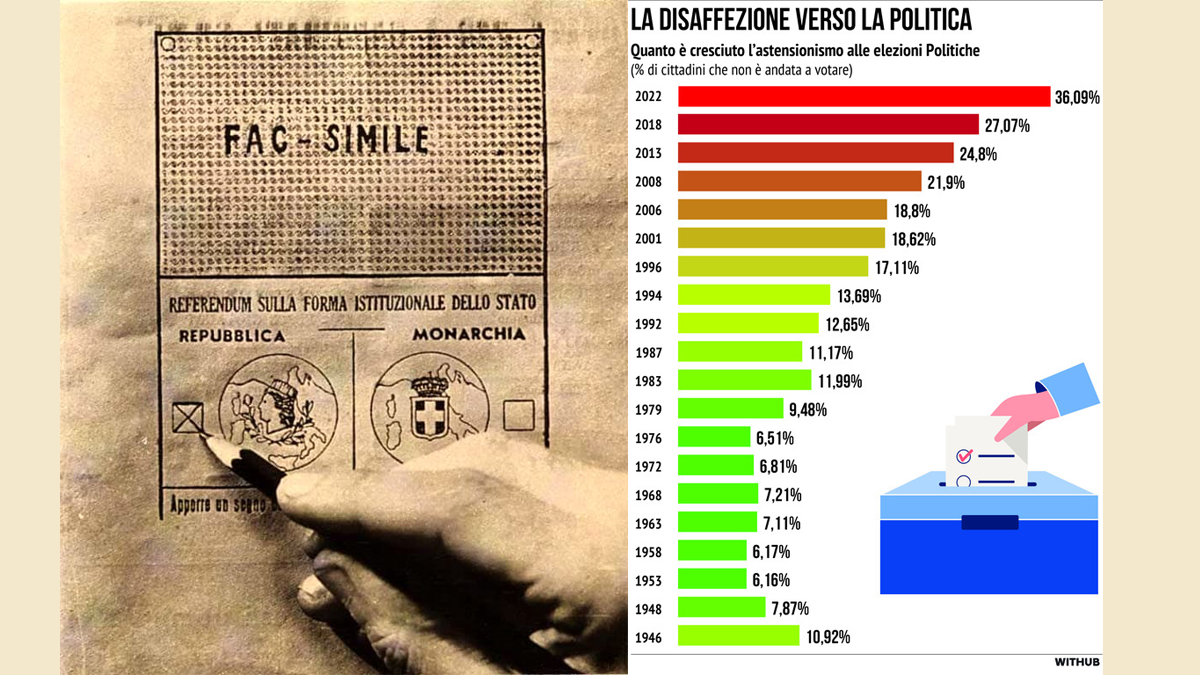Aveva diciassette anni Leletta, all’anagrafe Aurelia, quando nel settembre del 1943 la guerra irruppe nella sua casa. Viveva con il fratello Aimaro e i genitori, il barone Vittorio Oreglia d’Isola e la contessa Caterina Malingri di Bagnolo, nobili di antica casata piemontese di fede cattolica e monarchica, nella villa patrizia che sorgeva ai piedi d’un castello diroccato, a Villar, frazione di Bagnolo Piemonte, alle pendici del Montoso. Da quel giorno e nei venti lunghi mesi della guerra di Liberazione, il Palas, com’era chiamata la casa, fu il rifugio di partigiani, ebrei e perseguitati, teatro di eventi cruenti ma anche di un “esperimento” sociale e politico che in questa nostra epoca di squallidi egoismi e miopi calcoli politici ha del prodigioso.
Il racconto di quel che avvenne in quei luoghi lo dobbiamo al Diario di Leletta, che ci restituisce fatti e personaggi con la freschezza e l’immediatezza della gioventù, unite ad una lucidità sorprendentemente matura, a cominciare dalla figura di Pompeo Colajanni. Era questi un avvocato di Caltanissetta, richiamato durante la guerra come ufficiale di complemento e assegnato alla Scuola di cavalleria di Pinerolo, che dopo l’8 settembre entrò nella lotta partigiana con il nome di battaglia “Barbato”, divenendo il comandante partigiano della I Divisione Garibaldi Piemonte. Di “Barbato” si sono conservate alcune foto; la posa autorevole, lo sguardo fiero e intenso, i baffetti imperiosi: pare incarnare l’eroe partigiano, sensazione suffragata dai fatti e dalle testimonianze, che ne hanno tramandato il ricordo di un combattente coraggioso, sempre pronto a dare l’esempio, un capo che sapeva esercitare il comando con cautela e giudizio, e che nel 1945 con i suoi soldati liberò Torino dalle brigate nere. Ma Pompeo era anche un uomo di cultura, e tra lui e Leletta, malgrado la distanza siderale di estrazione sociale e fede politica, si instaurò subito un rapporto affettivo e intellettuale a prova di fuoco.
Attorno a loro, nelle stanze e nel cortile del Palas, si muoveva una folla eterogenea di figure, diversissime sotto ogni profilo ma che agivano con una inconsueta sintonia d’intenti: in quei giorni e in quei luoghi preti e partigiani, monarchici e comunisti, soldati meridionali e ufficiali dell’aristocrazia sabauda seppero dare il meglio di sé, superando antiche barriere ideologiche e sociali, storiche rivalse e rivendicazioni di casta, dando vita ad una realtà che rappresenta forse un unicuum nella storia d’Italia: si lottava uniti contro il passato, che i fascisti si ostinavano con violenza a perpetuare, e si progettava il futuro del Paese che sarebbe sorto da quella lotta di liberazione, fondato su solidi ideali di libertà, democrazia, giustizia. Questa forma di “Resistenza perfetta”, come l’ha definita lo storico Giovanni De Luna nel suo acutissimo e partecipato libro che a partire dal Diario di Leletta ricostruisce quegli eventi e quella straordinaria temperie, non è un anacronistico stereotipo della lotta resistenziale, bensì un dato di fatto che emerge dai documenti degli archivi comunali, delle parrocchie, dalla memorialistica e dai ricordi di un’intera comunità. Una “perfezione” che certo non appartiene a tutta l’esperienza resistenziale, com’è ovvio. Eppure, in quel particolare ambiente, in quel preciso momento storico, nel Palas si costituì come un laboratorio, a un tempo politico e umano, in cui donne e uomini dall’etica pulita anteposero agli interessi personali e al calcolo politico il bene supremo di una comunità nazionale da edificare su basi nuove e giuste.
E così, davanti ai nostri occhi attoniti di cittadini nati e cresciuti nella pace, scorrono le immagini della contessa Caterina e di sua sorella Barbara che a rischio della vita soccorrono rifugiati e partigiani feriti, li nascondono in baite e soffitte, s’avventurano in montagna per recuperarne i corpi senza vita; vediamo Leletta, studentessa del terzo anno del liceo classico di Pinerolo, affrontare con indomito coraggio i pericoli mortali di tedeschi e repubblichini, assistere feriti e moribondi, confortare i parenti delle vittime, svolgere pericolose azioni di messaggera partigiana, collaborare per la liberazione dei condannati a morte col parroco di Villar e con i salesiani; sfilano le immagini dei combattenti delle brigate Garibaldi, che alle azioni di guerra alternano nei saloni del Palas momenti di colta conversazione e di progetti per un futuro diverso; si materializza il repubblichino Novena, accusato di 195 omicidi, con la sua baldanza e il suo carico di spietatezza. Tutto narrato dallo sguardo acuto, sensibile, finanche saggio di Leletta, capace di interpretare quegli eventi terribili come una “scuola di vita”, di distinguere tra coraggio e viltà, innocenza e opportunismo, slancio ideale e calcolo gretto. E attraverso il suo racconto ci rendiamo conto che prima ancora di configurarsi come una decisione politica, l’antifascismo fu una reazione esistenziale, in nome della quale viene a fuoco il significato di una scelta che in quei luoghi e in quei momenti seppe accomunare aristocratici e comunisti, preti e mangiapreti, signori e contadini, monarchici e repubblicani, sconfessando clamorosamente le riletture storiche che hanno cercato di delegittimare e infangare il senso di un’esperienza pagata con il sangue, volta alla lotta d’un male e alla costruzione di un futuro migliore.
Dopo la guerra, Leletta seguì la sua vocazione religiosa, proseguendo un percorso di vita dedicata al prossimo. Morì nel 1993, sei anni dopo “Barbato”, che come lei nella vita civile continuò a battersi per gli stessi ideali di libertà e di democrazia. Nel 2012 si è aperta la causa per la sua beatificazione. La beata Leletta che aveva imparato ad usare il parabellum: come sa essere strana la storia, e quanto potrebbe insegnarci a non dimenticarla, a saperla interpretare.
Quaranta anni dopo la fine della guerra, nel 1985 Leletta scrisse a Barbato una commossa, lucida lettera, in cui compaiono questi stralci:
“Quel periodo tragico di guerra fu per noi, ancora nell’incoscienza della prima gioventù, una gloriosa epopea. La lotta per la libertà, per quella libertà che sotto il fascismo non avevamo conosciuta, l’incontro con personalità di adulti maturati nella persecuzione, le discussioni ideologiche sincere e vivaci, l’eroismo di alcuni e la simpatica semplicità di tutti furono davvero irripetibili e scuola di vita. Ho pensato ai giorni antichi della guerra, vissuta fra i 13 e i 19 anni, e li ho visti ‘veri’, liberi dall’eterodirezione dei massmedia, vissuti veramente da me. Li ho visti liberi, questi anni, dagli strati di lardo che il danaro pone sulle realtà essenziali della vita: prima fra tutte la morte. Di fronte ad essa, gli ideali politici – l’antifascismo che affratellava persone così diverse -, l’amicizia, la ricerca, la stessa povertà, acquisivano un rilievo del tutto speciale.”
Ecco, in queste intense parole c’è tutto l’insegnamento che oggi dovremmo ricavare da quegli eventi, da quelle persone, dalle loro scelte. La lezione di quei mesi di compattezza, di fusione d’intenti e d’ideali ci giunge come un monito, un indifferibile magistero, ancor più in questi giorni di profonda lacerazione, di disgregazione del tessuto politico, sociale e istituzionale. Oggi, come domani e sempre, non dobbiamo dimenticare che il Paese libero, democratico, repubblicano che abbiamo il lusso di celebrare ha preso vita grazie alle scelte di uomini come Leletta e Pompeo, al sacrificio di migliaia di individui che seppero ergersi al di sopra dei tempi feroci e cupi che il destino li costrinse ad attraversare, a donne e uomini d’una tempra morale di cui sembra si sia perso lo stampo. Davanti al loro esempio, alla loro memoria, noi omuncoli di questa scialba modernità non possiamo che inchinarci, cercando di recuperare tutti insieme il senso più profondo di quella lezione, consapevoli che questo sarebbe per loro il miglior ringraziamento.