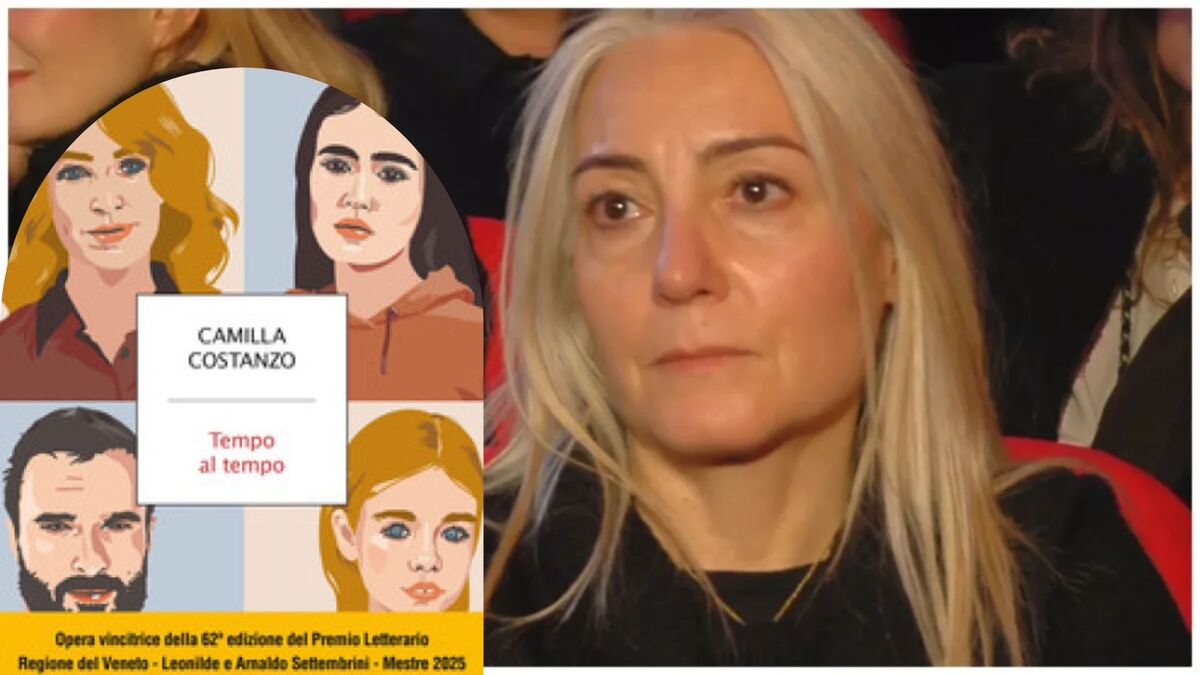di Alessia de Antoniis
«Questa cosa è accaduta e basta.» È una frase semplice, quasi infantile. Non c’è causa, non c’è colpa, non c’è destino. C’è un accadere che irrompe nella normalità come un corto circuito. Un corpo che si ferma. Un uomo che si immobilizza in una posizione assurda dopo un dolore alla spalla. E attorno a lui una comunità che non sa più come leggere il reale.
È L’Uomo di Legno –12/15 febbraio 2026 all’Argot Studio di Roma – scritto e diretto da Filippo Gili.
Tre uomini e un morto: tre falegnami allo stesso livello, senza gerarchie consolatorie. Filippo Gili, Massimiliano Benvenuto e Arcangelo Iannace sono un trio compatto, sincronizzato come un unico organismo: quando uno accelera, l’altro frena, quando uno cade nel balbettio, gli altri lo sostengono. Il ritmo è da elettrocardiogramma: picchi, piatti, ripartenze, ricadute. Non c’è alcuna disparità nella recitazione: nessuno mangia gli altri, nessuno resta indietro; e questa parità è anche la regola del gioco. Il rovescio è che, almeno alla prima, in alcuni snodi la precisione si sente troppo: l’impasto vocale diventa esercizio di controllo, l’inceppo appare coreografato.
«Apriamolo… Devo trovare il centro. È sicuramente lì il cuore del problema.» L’ intuizione drammaturgica di Filippo Gili è tanto semplice quanto spietata: di fronte al corpo che si blocca non scatta l’empatia, scatta il metodo. I tre falegnami non cercano una cura, non invocano un medico, non si interrogano sul dolore. Trasformano immediatamente l’uomo in materiale difettoso. In meccanismo inceppato. In oggetto di lavoro. La morte entra in scena come guasto tecnico che impedisce al meccanismo di funzionare.
Il lessico si sposta subito dal campo emotivo a quello artigianale, industriale, quasi chimico. Il corpo viene pensato come qualcosa che può essere smontato, pulito, sistemato, rimesso in funzione.
È in questo slittamento che lo spettacolo diventa perturbante. Non perché mostra la fine, ma perché mostra l’istinto contemporaneo a tradurre tutto in procedura. La morte, privata del suo alone simbolico, viene ridotta a problema tecnico da risolvere. Non è tragedia. È manutenzione.
Ma il cuore pulsante di L’Uomo di legno non è solo la situazione: è il linguaggio.
Quello che Gili costruisce è un vero e proprio nuovo idioma, una parlata sghemba, balbettante, fatta di ripetizioni ossessive, suoni che scivolano, parole che sembrano inventarsi mentre vengono pronunciate: “avventuntuto”, “svanzica”, “antifotofuori”.
A tratti sembra l’evoluzione colta della supercazzola di Amici miei: una lingua che si auto-legittima per ritmo, per musicalità, per accumulo. Ma sotto il gioco c’è qualcosa di molto più inquietante. Non siamo davanti a una mancanza di parole. Le parole esistono. Sono lì. Ma sembrano non volerle usare. Definiamola come più lieve… tipo una primavera dell’assenza.
Perché nominare significa dare forma. E dare forma significa accettare. Accettare la morte. Accettare la fine. Accettare l’interruzione. Meglio allora scivolare altrove, fuori dai codici, verso un linguaggio che non costringa a contestualizzare. «Contestualizza, spiega!». «Non lo so, non lo so, non lo so».
Non è ignoranza. È rifiuto del pensiero. È una difesa infantile davanti a qualcosa che fa troppo paura per essere detto. Si arriva perfino a suggerire che tutto può essere cambiato, anche le parole: “anche morto si può cambiare”. Come se rinominare potesse modificare il fatto.
E più la lingua si sfilaccia, più cresce l’aggressività. L’infantilizzazione avanza. Le decisioni diventano sempre più demenziali. Le soluzioni peggiorano i problemi. Le toppe sono sempre peggiori del buco.
I tre uomini continuano a “fare”, perché sono artigiani, perché l’azione è il loro modo di stare al mondo. Ma ciò che producono diventa sempre più inutile. Come lo ‘sgorbio’, un oggetto storto, malfatto che Gili mette in scena: la capacità tecnica sopravvive, ma ha perso il senso.
L’Uomo di legno è una feroce analisi sociale di una comunità che perde la competenza simbolica, che non sa più nominare il reale, ma continua a prendere decisioni vitali. Uomini ridotti all’incompetenza che governano comunque. È una visione che sfiora il grottesco ma affonda nel politico: la stupidità non come insulto, ma come categoria antropologica. Non ignoranza, ma auto-sabotaggio collettivo.
Dentro questo collasso cognitivo nasce il sacro. La “spalla”, da semplice sintomo fisico, si trasforma progressivamente in entità: una forza invisibile che avrebbe ordinato al corpo di bloccarsi, che governa l’inceppo, che forse punisce, che forse salva.
All’inizio è dolore. Poi volontà. Poi presenza immateriale. Poi principio superiore. Infine interiorità: “è dentro di me”. È esattamente il percorso con cui l’umanità ha sempre costruito le divinità. Prima il fenomeno inspiegabile. Poi la forza che lo governa. Poi il timore. Poi il culto. Poi l’interiorizzazione.
Ma se nella tragedia greca la morte era sempre destino, colpa, ordine cosmico, in L’Uomo di legno è pura interruzione. Non arriva come volontà divina. Arriva come collasso. E per questo gli archetipi non funzionano più. Davanti a un corpo che si inceppa l’uomo moderno non costruisce miti eroici, ma procedure, ipotesi tecniche, divinità improvvisate. Non Zeus. Non il coro. Ma la raspa, il martello, l’inventario.
«Togli tutto. Puliamo, bagniamo, asciughiamo e rimettiamo dentro.» È il cortocircuito dell’uomo moderno, che non sa più coniare scienza e fede. Che ha smesso di ri-cercare e ha ridotto il corpo umano a dispositivo. Se qualcosa non funziona: si apre, si smonta, si pulisce, si confronta, si rimonta. Come una macchina. Ma… Non è il caso di aprire uno di noi, vedere come siamo fatti dentro?
Per capire l’anomalia bisogna distruggere la normalità. Il guasto non è Gianfranco. Il guasto è la condizione umana. Una metafora micidiale del nostro tempo: analizziamo tutto così tanto da non lasciare più nulla intatto. La tecnica divora il senso. La procedura sostituisce il pensiero.
Con L’Uomo di legno, Gili torna da Beckett. Non per copiarlo, ma per lavorare sulla biologia che tradisce. Il suo non è citazionismo: è assimilazione strutturale. È teatro dell’interruzione contemporanea, non dell’assurdo novecentesco. Un teatro disturbante, comico, lucidissimo.
L’Uomo di legno di e con Filippo Gili, Massimiliano Benvenuto, Arcangelo Iannace
regia Filippo Gili
produzione Argot Produzioni
dove e quando Argot Studio, Roma – 12/15 febbraio 2026